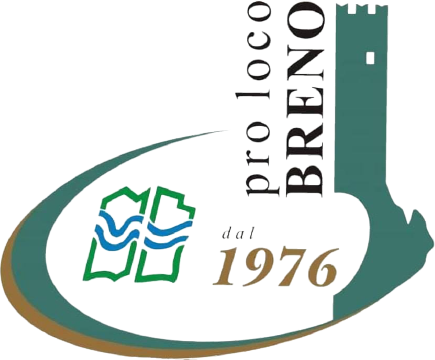Villa Ronchi
Villa Ronchi (La Casa Comunale)
Villa Ronchi, oggi palazzo municipale di Breno, fu progettata e realizzata da Fortunato Canevali sullo scorcio del secolo XIX, come residenza per l’ingegner Giovanni Antonio Ronchi (Breno, 1841-Brescia, 1914), di antica discendenza e che aveva avuto grande fortuna economica a Roma come impresario di costruzioni stradali, ferroviarie e abitative, grazie all’amicizia con Giuseppe Zanardelli, e che fu socio fondatore e primo direttore della Banca di Valle Camonica (1872-1873) e in seguito anche presidente (1904-1913).
Se Arturo Cozzaglio, descrivendo in modi romantici il suo ideale percorso di viaggio in Valcamonica, ricorda a Breno i “giardini e ville, che hanno per isfondo un bellissimo panorama dalle balde punte di granito”, parte del merito è anche della nascente villa Ronchi, situata nella nuova via S.Martino.
D’ispirazione tardo-neoclassica, la struttura del fabbricato è caratterizzata da estrema razionalità, che trova contrappunto in alcuni essenziali elementi decorativi connotati da una sfumatura d’eclettismo di fine secolo XIX, e si presenta distribuita su quattro livelli: il seminterrato, il piano rialzato, il primo piano e il sottotetto abitabile.
Le imponenti fondamenta, in parte poggianti direttamente sulla roccia che degrada verso nord, hanno permesso la costruzione delle ampie cantine dalle volte a botte, che richiamano la tradizione costruttiva tipicamente locale, con i volti alla base dell’edificio.
La facciata principale, sin dal notevole ingresso monumentale a gradinata simmetrica, è particolarmente ricca di misurati elementi decorativi: i pilastrini della balaustra da cui si diparte la raffinata presenza delle colonne di ghisa, cariche di eleganza formale, ma funzionali alla portata della balconata superiore; le ringhiere di ferro battuto, gli eleganti ed ampi balconi. Unico elemento puramente decorativo il fregio con le iniziali R(onchi) G(iovanni) A(ntonio), al centro della facciata principale, vezzo antico che ricorda l’importanza della casata.
Costituito da tre ordini, di cui il centrale leggermente più alto rispetto a quelli laterali, il palazzo si ritma modularmente per armonia: nello zoccolo di base si aprono le finestre dimezzate che danno luce al piano seminterrato, razionalmente corrispondenti e in asse con le aperture soprastanti in serie di tre per ogni corpo; degna di essere rimarcata poi è l’attenta proiezione delle cornici delle finestre; importante la collocazione dei marcapiani e delle incassature a finti conci, compatte nella parte inferiore e che evidenziano solo gli angoli nella parte superiore, che aiutano a percepire l’edificio nella sua articolazione; da notare anche, nella parte inferiore, la differenziazione dei finti conci dello zoccolo fortemente modellati rispetto agli altri dell’intera facciata, più lineari e poco rilevati.
Il corpo della costruzione, percepito dalla parte anteriore, risulta imponente, ma misurato, degno di una villa patrizia, anche per la presenza dell’originario vasto parco antistante, che permetteva una adeguata visione di campo, allestito con grotte di tufo, statue, fontana centrale e cancellata monumentale, oggi solamente intuibili attraverso alcuni residui invasivi.
Nella facciata posteriore, ben più possente, ma meno rappresentativa, forte è la presenza del piano interrato, con l’apertura delle tre arcate del porticato corrispondenti alla tripartizione che caratterizza l’intero disegno e che rendono meno pesante l’insieme. Anche qui la realizzazione del bugnato fortemente modellato si bilancia con la linearità dei finti conci del primo piano che diradano nel secondo e nel terzo, mettendo in risalto solo le parti angolari. I materiali e le soluzioni di costruzione sono essenzialmente quelli della tradizione, sapientemente impiegati e lavorati dalle maestranze locali:
l’edificio, alla base, sempre rigorosamente realizzato in pietra, si alleggerisce superiormente con l’utilizzo del laterizio e viene protetto esteriormente dall’intonaco a calce, diverso nei differenti livelli; le pietre, il marmo di Botticino e il granito vengono impiegati rispettivamente per le cornici modanate delle aperture e per gli imponenti pilastri delle cancellate; l’impiego “modernista” delle persiane scorrevoli a scomparsa, risulta ideale per non appesantire le facciate con elementi invasivi.
L’interno, dallo schema caratterizzato dal corridoio centrale che si collega ai locali laterali, è pensato per una signorile residenza e si presenta sontuoso.
Nel piano seminterrato erano collocate le cucine, collegate alla superiore sala da pranzo attraverso un montacarichi passavivande, la dispensa e alcuni vani accessori.
Al piano nobile, dopo l’ampio ingresso principale, nel cui soffitto è dipinta una composizione geometrica e floreale che racchiude gli stemmi delle maggiori città italiane, a simboleggiare l’unità d’Italia (da sinistra: Venezia, Napoli, Bologna, Firenze, Roma, Milano, Palermo, Torino), trovavano posto le stanze della zona-giorno, con l’elegante salone destinato all’ascolto e all’esecuzione della musica (ora sala del consiglio
comunale) cui la famiglia brenese era particolarmente dedita.
Il soffitto del salone della musica è affrescato da Ponziano Loverini (Gandino, BG, 1845-1929) con l’Allegoria della musica drammatica (1895): in figura di donna, posta nel cielo sopra un nimbo rosato al centro della composizione, che guarda verso l’alto, il capo cinto d’alloro e circondato dalla luna piena e da una stella (perché fonda la sua armonia nei cieli), la Musica tiene nella mano una cetra d’oro e ha ai suoi piedi uno stiletto e una maschera tragica; a lato alcuni putti suonano strumenti musicali e sopra, portati da un raggio di luce, due amanti sono rapiti in un bacio appassionato; al di sotto, un’aquila volante, simbolo dell’ingegno, reca nel becco un serto di alloro ai compositori (in cui si riconoscono G. Verdi, G. Rossini, V. Bellini, A. Ponchielli, G. Donizetti, P. Mascagni e G. Puccini) che si affacciano da una balaustra,coperta da un drappo rosso e posta su una scalinata degradante, su cui siede un putto, posto su un cuscino di velluto blu, che mostra un volume con l’iscrizione “MUSICA DRAMMATICA”;
Nel salone erano anche collocate due grandi tele (rimaste in proprietà agli eredi), dello stesso maestro, raffiguranti episodi teatrali della Favorita di G. Donizetti e del Rigoletto di G. Verdi, del 1897.
Ancora sullo stesso livello vi era la sala da pranzo (attualmente ufficio del sindaco), impreziosita dagli stucchi di Canevali, rappresentanti, in un tripudio di decorazioni con putti, naiadi e fauni che si fondono con elementi vegetali, fiori, frutta e volatili, l’Allegoria del brindisi (1896), accanto erano posti anche il salotto ed uno studiolo.
Al primo piano vi erano le camere, i guardaroba ed alcuni salotti; nell’ampio sottotetto erano poste i locali della servitù e alcuni guardaroba. Molte stanze presentano affreschi, di autore anonimo, con motivi decorativi geometrici, floreali, naturalistici paesistici e fantastici di gusto pre-liberty, che ricordano gli affreschi che erano presenti nel palazzo brenese dell’avvocato Paolo Prudenzini.
Le stanze erano poi arricchite da sculture lignee e intagli, ad opera di Canevali, in parte ancora oggi visibili nella loro sistemazione originaria, come l’appendiabiti, la specchiera ed il copricamino, da mobili preziosi, quadri, arazzi, camini e lampadari di vetro di Murano e di ferro battuto che in gran parte sono stati svenduti nel 1946 e in parte si sono perduti per l’incuria o per la scaltrezza di qualcuno.
Rimane, ancora posta nell’atrio, la grande tela con scritta “Opera del Cavalier Andrea Celesti” (Venezia 1637- Toscolano BS, 1712), più probabilmente di autore anonimo
del secolo XVIII, raffigurante Mosè salvato dalle acque, lasciata in dono al Comune di Breno dalla signora Cattina Ronchi in Romelli, in ricordo dei figli.
Il palazzo fu completato con i pavimenti lignei posati dalla ditta Ongaro di Breno, quelli in tessere policrome dovuti alla ditta Pedretti di Bienno su disegno dell’architetto Mario Ippoliti (Osimo 1893-Breno 1988) nel 1937, quelli in graniglia al primo piano, in cotto nel sottotetto.
Da ricordare anche il grande scalone, in marmo di Botticino e ringhiera in ferro battuto, che dal seminterrato porta al primo piano.
A seguito della caduta del regime fascista e a causa dei rivolgimenti politici, essendo la famiglia impegnata politicamente ed avendo ricoperto Giovanni Ronchi la carica di podestà, molti arredi e suppellettili vennero frettolosamente svenduti e la villa fu donata al Comune con lo scopo di collocarvi strutture di pubblica utilità, come testimonia anche una targa commemorativa posta nell’ingresso:“Questo palazzo divenne proprietà del Comune di Breno per liberalità disposta ed attuata dai fratelli Ronchi in memoria dei loro genitori ing. Gio(vanni) Battista Ronchi e Bice Caldani”.
Nei primi anni Sessanta un grande intervento, già da tempo previsto anche in un progetto dall’architetto Vittorio Montiglio, vide la risistemazione del parco antistante la villa, con la demolizione della grande recinzione, il ridimensionamento dei giardini e il drastico riadattamento della graziosa palazzina posta a fianco della dimora.
Lo stato attuale, in risposta alla funzionalità di un municipio, risulta dignitoso e permette la lettura e la visita da parte dei cittadini.
Villa Montiglio-Taglierini
Villa Montiglio
Non è facile stabilire con esattezza la data di costruzione della villa, ma è certo che quando il notaio Pietro Taglierini (nato a Borno nei primi anni del XVIII secolo) si trasferì a Breno acquistò una casa con casci-nale e ampio terreno circostante.
Nel corso degli anni il notaio ampliò la villa e dedicò molta cura anche al cascinale e al terrazzo. Alla sua morte la proprietà passò al figlio Stefano (1769-1846) che continuò l’opera paterna completando la ristrutturazione della casa e creando un parco separato dal terreno agricolo.
Nel 1846 gli succedette il figlio Antonio (1815-1891), personaggio eminente sia in campo giuridico che in quello amministrativo-politico.
Fu consigliere provinciale e poi deputato del Parlamento Italiano; grande amico di Benedetto Cairoli ebbe anche l’onore di ospitare, nella villa di Breno, il futuro re Umberto I e il duca Amedeo d’Aosta durante una loro visita ufficiale in Valle Camonica. Cittadino benemerito, fu tra i fondatori della Banca di Valle Camonica e della Società Operaia di mutuo soccorso.
Fu lui che acquistò la proprietà degli eredi Giacomelli Gianmaria, il grande complesso di Marianna Ronchi (già Griffi-Sforza) e il brolo di Antonio Sigismondi. L’acquisto deve essere avvenuto dopo il 1860 perché la “Planimetria della nuova strada di attraversamento del centro abi-tato di Breno”, eseguita da Isidoro Rizzieri nel 1860, riporta ancora due proprietà confinanti: quella dei Taglierini e quella degli eredi Giacomelli.
Se l’acquisto delle proprietà Giacomelli e Ronchi Sigismondi è successivo al 1860, si può ipotizzare che la villa e l’adiacente villino siano stati realizzati verso la fine dell’800, prima ancora che sorgessero, lungo l’arteria principale del paese, le altre ville importanti (Villa Ronchi, De Michelis, Canevali e Gheza).
L’eclettismo che caratterizzerà il novecento e che in Breno giungerà all’apice con Villa Gheza, sembra aver già trovato segnali in Antonio Taglierini.
Per la realizzazione della villa si affidò ad un architetto predisposto all’innovazione che seppe fondere elementi nuovi con elementi tradizionali ottenendo un’insolita, ma non disarmonica commistione tra architettura alpina e decorazioni “Liberty”.
Alla morte dell’Avvocato, la proprietà passò al figlio Giuseppe (1851-1896) che volle rinnovare la facciata della Villa e dare un nuovo assetto al parco.
Con l’aiuto dell’avvocato Zanoncelli da Lodi (fratello della moglie Maria e grande appassionato di giardinaggio) il parco fu ridisegnato: vennero tracciati sentieri in ghiaietto, create nuove aiuole, piantumate altre essenze arboree, realizzate grotte in tufo di cui una a ponte sulla quale fu poi aggiunta una statua.
Fu poi decorata la facciata della villa e l’avv. Zanoncelli disegnò personalmente i fregi con foglie d’acanto.
Anche la cascina subì notevoli trasformazioni e venne poi utilizzata come scuderia.
Alla fine dell’800 purtroppo scoppiò un terribile incendio che arrecò ingenti danni alla villa. I Taglierini dovettero abbandonare l’abitazione e trasferirsi nella dependance che venne completamente ristrutturata e abbellita con l’aggiunta di uno sbalorditivo.
Alla morte di Giuseppe i suoi beni passarono ai figli Antonio e Beatrice. Purtroppo l’ingegnere tenente Antonio (1889-1917) morì combattendo sul Carso; aveva però lasciato un testamento in cui disponeva che il suo patrimonio fosse lasciato ai Brenesi “a parziale sollievo di tante miserie e al miglioramento morale del paese natio”.
Questo importante lascito consentì l’acquisto di una colonia marina (che portò il suo nome) per un migliore sviluppo fisico dei bambini, di contribuire alla costruzione dell’Ospedale, delle scuole e di offrire un sostegno ad anziani e bisognosi.
Beatrice Taglierini, agli inizi del 1900, aveva sposato l’ingegnere piemontese Giovanni Montiglio e lo aveva seguito a Roma dove lavorava per l’”Ansaldo”.
Rimase però sempre legata a Breno dove ritornava spesso e dove si trasferì definitivamente quando il marito si mise a riposo.
Dal loro matrimonio erano nati cinque figli: Iolanda, Vittorio, Maria Antonietta, Ottavio e Antonio. Iolanda restò a Roma dove si era sposata e Maria Antonietta morì a soli cinque anni. A Breno rimasero solo i tre maschi: Vittorio, Ottavio e Antonio.
A Vittorio era stato dato il nome dello zio Vittorio Montiglio, il fanciullo soldato che a soli quattordici anni fuggì dell’America del Sud per raggiungere i fratelli Umberto e Giovanni, volontari della prima guerra mondiale (entrambi “medaglia d’argento” per essersi rispettivamente distinti nella battaglia del Piave e in quella del monte Cimone).
Vittorio, falsificando il certificato di nascita, riuscì ad arruolarsi fra gli Arditi del battaglione Feltre. A quindici anni era già sottotenente, successivamente divenne ufficiale e fu anche legionario con D’Annunzio. Per il suo coraggio e le sue audaci imprese gli fu attribuita la medaglia d’oro. Anche Vittorio, come lo zio, dimostrò, fin dalla più tenera età, audacia, coraggio e grande fermezza. Soldato quando era ancora studente, si laureò in architettura a Roma nel 1941 con il massimo dei voti. Durante un bombardamento nei pressi di Viterbo fu gravemente ferito agli arti inferiori, fu ritrovato solo il giorno seguente in condizioni disperate. Fortunatamente si riprese, ma una gamba dovette essere amputata e l’altra rimase paralizzata.
La sua straordinaria forza di volontà e il suo spirito d’iniziativa lo spinsero a progettare un arto artificiale più leggero e più comodo (ci sono ancora i disegni) con cui sostituì l’arto pesantissimo e sco-modo che gli era stato applicato in ospedale.
Non è possibile elencare le molteplici attività e le copiose opere che caratterizzarono la sua breve esistenza.
Fu appassionato di sport, (fu alpinista, cavallerizzo, nuotatore, sciatore e pattinatore), di meccanica, di pittura, di scultura, musica, ma soprattutto di architettura e in tutti questi campi diede prova di straordinarie capacità.
Purtroppo però il 27 aprile 1953, a Boario, dove stava seguendo i lavori per la costruzione della Chiesa degli Alpini (ultimo suo progetto), la sua vita fu tragicamente stroncata dal passaggio di un treno del cui arrivo non era stato avvertito in tempo.
Negli anni successivi si spense la madre Beatrice e più tardi il Dott. Ottavio di cui resta un ricordo molto vivo per l’indiscussa competenza professionale, la grande disponibilità e anche per la sua passione sportiva.
Ora a Breno vivono l’ultimo figlio di donna Beatrice, l’architetto Antonio che fu anche sindaco di Breno, i suoi figli e quelli del dott. Ottavio e a loro spetterà il compito di conservare con cura, così come è stato fatto finora, la villa, il villino e il parco.
La villa, a tre piani più il sottotetto, è caratterizzata dalla terrazza panoramica, elemento ricorrente nelle composizioni architettoniche del tempo (come le pregevoli cancellate e le ringhiere in ferro battuto degli ingressi e della terrazza) da cui godere lo spettacolo della natura circostante.
Accanto alla villa grande s’innalza anche un villino, ovviamente di dimensioni più ridotte, ma di grande interesse architettonico per l’insolita commistione di stili. Decorazioni “Liberty” sono presenti, oltre che all’esterno anche nell’interno degli edifici.
Villa Gheza
Villa Gheza
Nel cuore di Breno, al numero 1 di via Mazzini, si erge un edificio la cui assoluta estraneità a modelli storici consolidati in Valle Camonica disorienta chi lo vede per la prima volta. E’ Villa Gheza, testimone dei successi imprenditoriali dell’ avv. Maffeo Gheza che progettò e curò, con meticolosa precisione, ogni più piccolo particolare della costruzione. Personaggio straordinario, aperto al progresso, assetato di nuove conoscenze e di nuove esperienze, l’avv. Gheza fu sicuramente condizionato dalla cultura orientalista europea di fine Ottocento e inizi Novecento.
Pur non avendo mai visitato alcun paese influenzato dalla cultura araba, alimentò il suo interesse per quell’Oriente, che nell’immaginario collettivo degli anni venti entrava con forza, rac-cogliendo pubblicazioni e fotografie, visitando mostre ed esposi-zioni e consultando il suocero, prof. Otto Penzig, famoso docente di botanica presso l’Università di Genova il quale aveva viaggiato a lungo in paesi lontani.
Maffeo Gheza però, nel 1929, non dette solo inizio alla realizzazio-ne della sua Villa, ma anche alla costruzione di un monumento che testimoniasse il successo ottenuto con anni di intenso lavoro. La ricerca di preziosità e di lusso che caratterizza questa Villa in cui lo stile orientale si fonde con le mode occiden-tali del tempo, è da considerarsi come antidoto alla crisi dilagante in quegli anni.
Ispirandosi ai valori del capitalismo illuminato e dell’ impegno sociale per il riscatto dei figli del popolo attraverso il lavoro, Maffeo Gheza, utilizzando maestranze locali, e saltò la qualità del lavoro artigianale in contrapposizione al lavoro in serie, che in quegli anni si stava rapidamente diffondendo.
Oggi la Villa, nonostante la sua “giovane età” (non ha ancora compiuto cento anni) può, a buon diritto, essere annoverata tra i beni culturali da studiare e da tutelare.
Il complesso architettonico, completato esternamente nel 1935, consta di un seminterrato e di tre piani, ma solamente una parte del piano terra è stata ultimata secondo il disegno dell’avv. Gheza.
Il secondo piano presenta infatti poche decorazioni e il terzo piano è ancora “al rustico”: ne sono prova i molti disegni delle decorazioni che l’avvocato intendeva realizzare.
L’accesso al giardino e alla Villa è contraddistinto da un tipico arco arabo, sostenuto da fasci di sottili colonne e decorato con simboli e motivi geometrici, sotto il quale inizia il grande viale pavimentato con ciottoli bianchi, neri, rossi e verdi disposti secondo un preciso disegno e la larga scala curvilinea che conduce all’ingresso principale.
Il viale che percorre il giardino si articola in una serie di vialetti che si snodano tra agavi, palme, jucche e bambù, grotte e laghetti, balaustre e panchine, lampio-ni e fioriere.
La vegetazione mediterranea, scelta forse in omaggio al celebre suocero, prof. Otto Penzig, è costituita da piante provenienti da zone del lago d’Iseo perché potessero più facil-mente acclimatarsi in Valle Camonica.
Il giardino, che forma un tutt’ uno con la Villa, è circondato da un possente muro ricco di iscrizioni e di simboli ancora in gran parte da studiare, come del resto anche quelli presenti nell’edificio.
Ci sono simboli massonici, islamici, ebraici, frammisti a lettere italiane e latine
I messaggi graffiti sul muro di cinta e sulla villa stes-sa, rivelano ancora una volta il carattere e l’ideale di vita dell’avv. Gheza, uomo orgoglioso che persegui-va con ostinazione i suoi obbiettivi incurante del giudizio degli altri.
Si possono leggere per esempio:
– “Spetta all’ uomo conquistarsi la vita di lui degna”;
– “L’avvenire sarà di chi non lo avrà temuto”;
– “Raddoppierete il frutto del lavoro eseguendolo con entusiasmo“;
– “La gente dice che cosa dice lasciamola dire”.
Forse però il segreto di molti simboli resterà sepolto per sempre per una precisa volontà dell’avvocato.
I disegni delle decorazioni furono elaborati con la collaborazione anche dell’architetto decoratore bergamasco Eugenio Bertacchi e i lavori sugli intonaci e in cemento furono realizzati dalle ditte camune Cappellini e Putelli, che dimostrarono straordinarie capacità artigia-nali.
La pianta rettangolare della villa richiama più i modelli architettonici italiani che modelli moreschi, ma sicuramente di influenza araba-indiana sono il tetto-terrazza che un tempo ospitava i giardini pensili, lo spettacolare belvedere ottagonale e il lungo porticato di stile moresco che si specchia in un laghetto alimentato da cascatelle.
Sempre di influenza orientale è l’ingresso al piano nobile, costituito da una sala poligonale che, al centro, ha una fontana con lampada opalinata sulla quale scorreva l’acqua. Intorno all’atrio si aprono la sala da pranzo, la cucina, il salotto della musica, lo studio e la camera da letto.
La sala da pranzo si affaccia sul jardin d’hiver chiuso da vetrate di stile neogotico; più che una serra vera e pro-pria era una grande veranda da poter sfruttare soprat-tutto nei periodi invernali. Lo fa supporre la presenza, nel locale, di una sorta di scaldavivande inserito nel termosifone.
Oltre alla stupenda sala da pranzo il locale che suscita maggior interesse per la ricchezza delle decorazioni e l’originalità dell’arredamento è senza dubbio la camera da letto. Soffitto, pareti e pavimento sono interamente decorati con tecniche e materiali molto diversi e preziosi ma che si fondono senza contrasti. La fusione tra orientalismo ed eclettismo è molto evidente nell’arredamento, soprattutto nei letti in noce, con intarsi e particolari in rame e mosaici in madreperla.
Realizzati da Alfredo Cappellini su progetto dello stesso Gheza, si ispirano ai mobili Bugatti molto ammirati in quegli anni.